Il Centro internazionale di studi Primo Levi promuove le Lezioni Primo Levi. Vengono presentate a Torino, una all’anno, e ciascuna è incentrata su un tema legato agli interessi di Levi, per imparare a leggere le sue opere.
I libri delle Lezioni Primo Levi sono pubblicati da Einaudi in doppia lingua, inglese e italiano.
Perché crediamo a Primo Levi? ha 184 pagine, suddivise in tre parti: la lezione vera e propria e due appendici (la prima raccoglie sei tra testi e lettere di Primo Levi, Jean Samuel e Paul Steinberg; la seconda è la rielaborazione di un colloquio tra Barenghi e gli studenti di un liceo di Orbassano avvenuto il giorno dopo la Lezione).
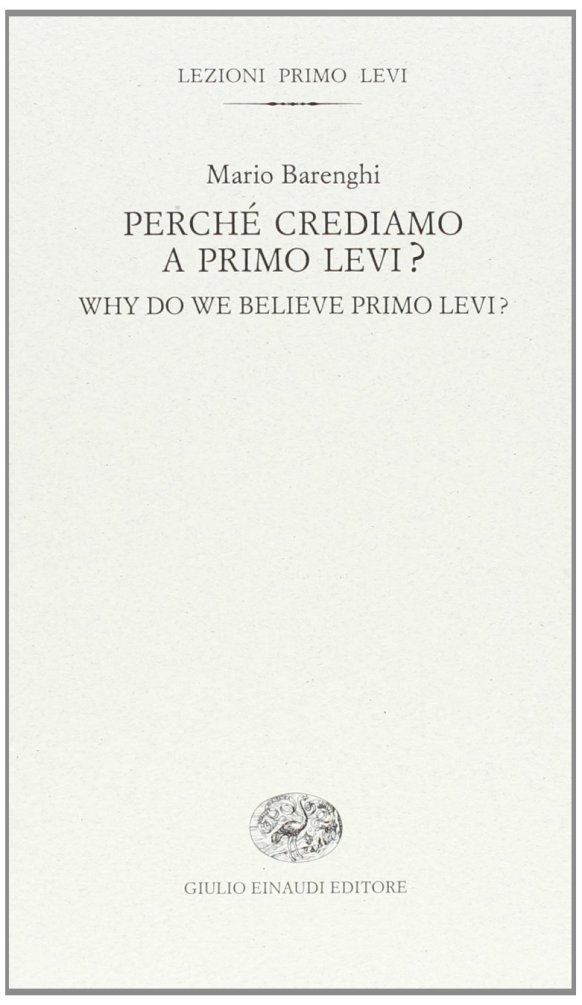
La Lezione è un ragionamento sul tipo di veridicità che attribuiamo a Primo Levi e in particolare a Se questo è un uomo. La questione si può scomporre in due aspetti: l’oggetto, cioè che cosa riteniamo vero, e il motivo, cioè perché lo reputiamo vero.
Prendiamo il capitolo Il canto di Ulisse: Jean Samuel, il Pikolo di Se questo è un uomo, ricorda poco di quell’episodio, ma ricorda il progetto di Carbonio e una conversazione con Levi durante un attacco aereo. Levi, dal canto suo, scrive alcune inesattezze, come l’età di Jean Samuel. Ma la verità dell’episodio non sta nella sua corrispondenza con i fatti, bensì nel valore morale di quell’esperienza.
La memoria lavora a servizio del futuro, non del passato, rielabora le informazioni e organizza in continuazione il vissuto, dandogli una forma adatta per essere presentata ai lettori. La strategia narrativa di Se questo è un uomo si basa su “una precisa economia della memoria” data dalla ponderazione delle informazioni e dalla distinzione tra memoria personale e collettiva. La selezione delle informazioni risponde alla volontà e all’esigenza di raccontare esperienze estreme con la consapevolezza dell’impossibilità di dire tutto e dell’inutilità di accumulare particolari superflui. Il carattere traumatico dell’esperienza dei reduci rende difficile il distacco dai fatti, i ricordi sono vividi e possono sopraffare. Allora il racconto non è rievocazione, ma diventa il modo per prendere le distanze dai fatti, renderli presentabili agli altri e farsi memoria collettiva.
Dunque: a cosa crediamo. Alla poesia d’apertura, sintesi in nuce di Se questo è un uomo, al libro intero come resoconto dell’esperienza del Lager, e a tutto il corpus di testimonianze e riflessioni sul tema. Ci crediamo per la sincerità e l’autorevolezza della scrittura di Levi, per il suo stile pacato e razionale, soprattutto per il suo “impegno a trasformare l’esperienza del Lager in un’occasione di conoscenza”. La ragione più profonda è il paradosso: davanti al paradosso di Auschwitz, anche nella testimonianza di Levi restano degli aspetti paradossali. Questo ne aumenta la credibilità. Non vi è liberazione in Se questo è un uomo. Più che autobiografia è “lo studio dell’uomo in genere”. Volendogli dare una forma potremmo pensare a un’ellisse, o meglio un’ellisse aperta: una curva. I due fuochi si trovano al di fuori del testo. Il primo fuoco è il dislivello tra la premessa in prosa e l’epigrafe in versi, quindi tra la presentazione di “documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano” e il tono solenne della poesia Shemà. Il secondo fuoco è l’episodio di Hurbinek, nella Tregua, che è anche l’apice di un climax dato dalla sequenza di tre casi di morte in Lager. Il primo – nel capitolo L’ultimo di Se questo è un uomo – è l’impiccagione di uno degli insorti di Birkenau; riflettendo sulle circostanze dell’esecuzione, il protagonista si ritrova sul fondo, tra vergogna e sconforto. Il secondo – nel capitolo Storia di dieci giorni – è un compagno di baracca morto poco prima della liberazione in un delirio di remissione e con fatica. Il terzo è Hurbinek, un bambino che non sa parlare ma prova ad articolare parole o variazioni della stessa parola che restano però indecifrate; nulla rimane di lui se non la testimonianza di Levi. Nei racconti dei tre episodi cresce l’autocoscienza del testimone. Da messaggero di un’emozione momentanea a testimone autorevole che riferisce i fatti consapevole dell’importanza di raccontarli: raccontare per vincere il nulla, per ricordare, per tenere aperto un discorso sul passato.
Dunque: perché ci crediamo. Perché Primo Levi costituisce un paradosso, inteso come voce architettonica, variante di paradorso, che è l’immagine della provvisorietà: “l’edificio dell’umano è precario” e in Levi non troviamo salvezza né comprensione.
Roberta Garavaglia

